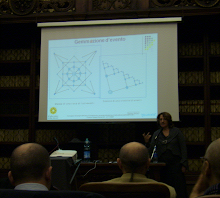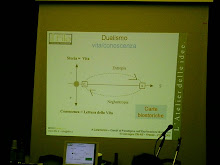- 1. Per un’Epistemologia della Mente e della Vita
In uno dei “meta-loghi” scritti con la figlia Mary Catherine e poi apparsi in volume nel 1987 con il titolo Angels Fear – Towards an Epistemology of the Sacred,[1] c’è un’espressione di Gregory Bateson che riassume il lavoro e la visione di un’intera vita saltando in blocco l’annosa questione delle “due culture”: Il bello e il brutto, il letterale e il metaforico, il sano e il folle, il comico e il serio… perfino l’amore e l’odio, sono tutti temi che oggi la scienza evita. Ma tra pochi anni, quando la spaccatura fra i problemi della mente e i problemi della natura cesserà di essere un fattore determinante di ciò su cui è impossibile riflettere, essi diventeranno accessibili al pensiero formale.
In questa frase, come spesso accade con la scrittura di Bateson, c’è il sapore “zen” di una provocazione che ci sfida a rimettere in discussione l’identità della scienza occidentale in alcuni dei suoi presupposti più profondi e radicati che rischiano dunque di rimanere invisibili con la forza sommersa di un luogo comune.
Questo bisogno di attraversare piani diversi del discorso, di porre in gioco più meta-livelli fino a portare alla luce relazioni complesse, connessioni irrisolte e circoli viziosi, è già parte del sapere che Bateson ci ha lasciato con un’eredità geniale, frammentaria e confusa, spesso male interpretata, ma soprattutto prematura, che rischia di restare ancora una volta inascoltata nel tempo del “supermarket di Prometeo”.[2]
L’aforisma di Bateson, infatti, non può che apparire sterile se lo si interroga dando per scontata l’immagine tradizionale della scienza, ossia mettendo sullo stesso livello i modelli matematici che descrivono “galassie e palle da biliardo” e quegli aspetti irriducibili della vita e della cognizione che le scienze umane, l’esperienza artistica, e la sapienza del terapeuta hanno imparato a conoscere e praticare, aspetti con i quali ognuno di noi, scienziato o no, deve fare i conti quotidianamente. Per comprenderla è necessaria la paura degli angeli, la sottile agilità che permette al pensiero di muoversi su piani diversi e svelarne le complesse articolazioni senza mischiarli o forzarli.
È noto che i successi della fisica classica, per intenderci quella che va dalle particelle di Newton ai campi di Maxwell fino allo spazio-tempo di Einstein, ha prodotto una nozione di epistemologia come “metodo” in grado di risolvere il mondo in forme semplici e regolari, producendo modelli matematici di grande forza predittiva. L’avvento della fisica quantistica e più recentemente dello studio dei sistemi non-lineari, la cosiddetta fisica del caos, ha mostrato le corde di alcuni assunti classici, come il riduzionismo o il legame tra determinismo e predicibilità. La speranza però di trovare nella logica quantistica o nello spazio delle fasi dei sistemi caotici strumenti concettuali in grado di fornire suggestioni utili alle scienze umane si è rivelata largamente infondata, lasciando il territorio tra le scienze “hard” e quelle “soft” aperto ai più sommari tentativi di unificazione forzata o alle improbabili suggestioni del pensiero new-age.
http://samgha.wordpress.com/2010/05/20/comunicazione-emergenza-apertura-logica-parte-ii-ignazio-licata-2007/